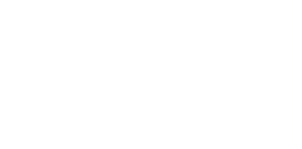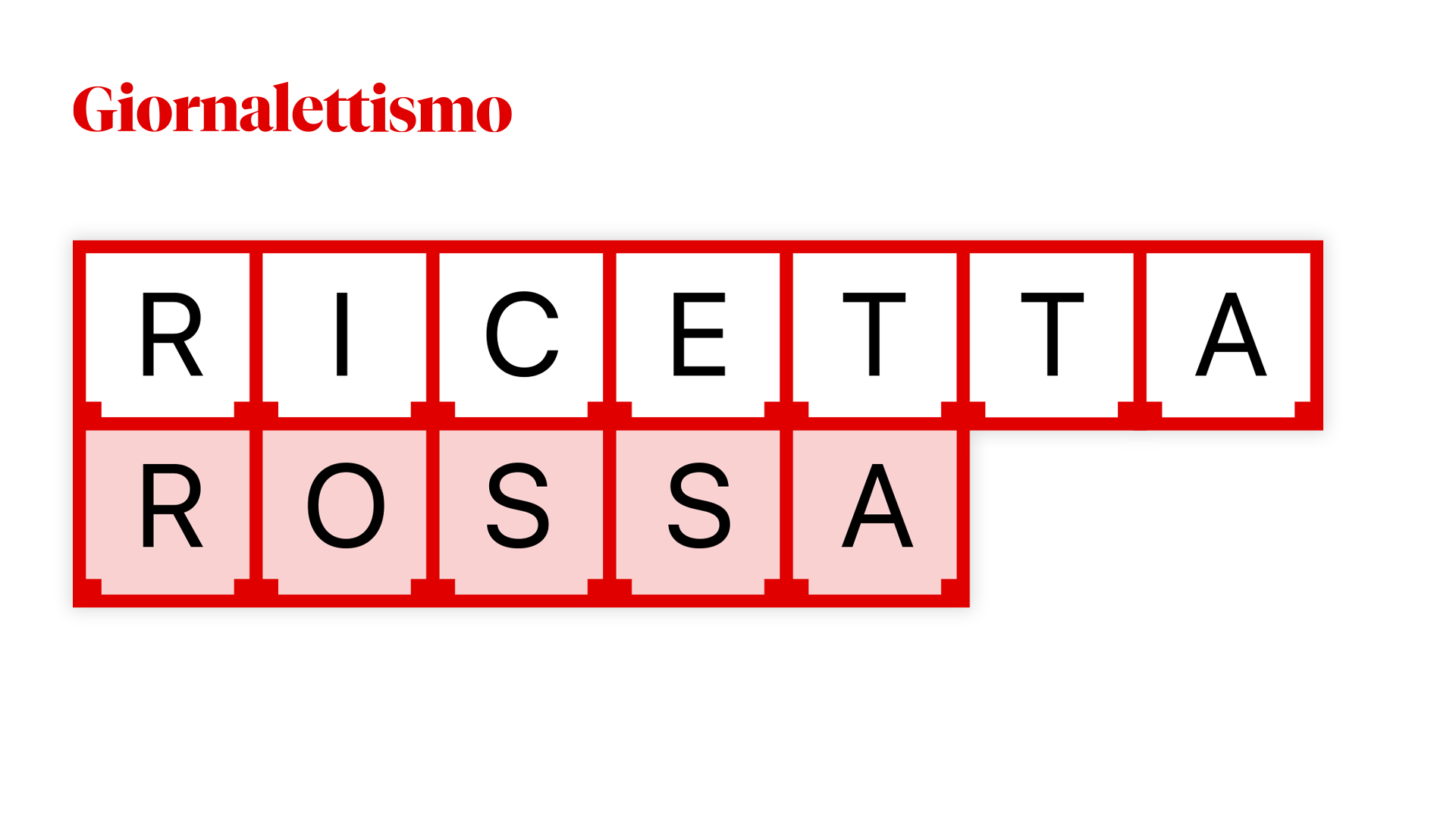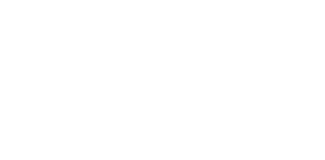La legge delle tre i
27/02/2016 di Clementina Coppini
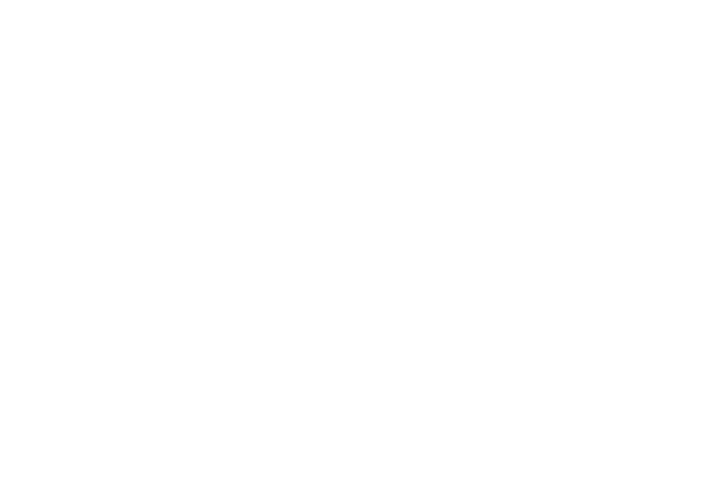
Seppelliamo i nostri scrittori e riempiamo i social di loro immagini, frasi e pensieri. Ma ci riflettiamo sopra ai nostri copincolla? Il 19 febbraio sono morti Umberto Eco e Harper Lee. I loro romanzi più noti, come a tutti è noto (tutto ormai è noto a tutti, almeno per un paio d’ore), sono rispettivamente Il nome della rosa e Il buio oltre la siepe. Il nome della rosa è la storia di un monaco assai intelligente e assai balengo che investiga su strane morti in convento e scopre che esse sono generate dal terrore che una risata possa seppellire l’ignoranza, l’insipienza e l’intolleranza, le fondamenta della Legge delle tre i che governa gli stolti a cui piacerebbe che il Medioevo dei loro sogni (quello di Bernardo Gui, il brutto cattivo inquisitore, non certo quello di Guglielmo da Baskerville, il monaco illuminato) non finisse mai. Perché, si sa, per alcuni è meglio bruciare i libri e far finta di non sapere che leggerli e capire che in fondo non c’è niente di così terribile nel comprendere una visione diversa della realtà, così come ridere e piangere sono due emozioni opposte ma ugualmente legittime.
C’è un nero accusato ingiustamente di stupro, Tom, difeso da un avvocato bianco, Atticus Finch, che per motivi culturali e ambientali non è poi così tanto liberal ma più conosce il suo cliente più capisce che insomma il razzismo non è una gran bella cosa. È vedovo con due figli che guardano strano il vicino di casa Boo, che è uno psicolabile e per questo viene tenuto recluso in casa. Il titolo originale, To kill a mockingbird (uccidere un usignolo), si riferisce a una frase che il padre dice ad Atticus da ragazzo mettendogli in mano il suo primo fucile (sono americani, loro si credono sempre nei film di John Wayne). Gli dice che con quello può sparare a tutto eccetto che agli usignoli, perché non fanno male a nessuno. Atticus capirà quanto sia difficile proteggere l’usignolo Tom dai fautori delle tre i e i suoi figli verranno salvati in extremis da Boo il diverso.
Perché alla fine, quando hai bisogno e sei in pericolo, non ti interessa più di che razza o fede religiosa od orientamento sessuale sia la persona che ti aiuta. Perché alla fine, quando cominci a ragionare con chi è diverso da te, è lì che si comincia a ragionare, appunto.
Il nome della rosa finisce con una frase in latino: Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus. C’è tutta una menata intellettuale dietro questa frase (pregasi guardare Wikipedia et similia) e mille domande sono state poste a Umberto Eco, insigne semiologo, riguardo all’argomento. E lui aveva anche provato a rispondere, ma, da mente illuminata qual era, aveva deciso di porre a sua volta una questione alternativa: “La mia domanda è un’altra: possibile che non abbiate niente di meglio da fare?” Ecco, appunto. Davvero non si ha niente di meglio da fare che impicciarsi in modo morboso della quotidianità altrui?
E allora, tornando alla nostra legge delle tre i, non possiamo fare tesoro dell’insegnamento del nostro maestro recentemente scomparso e, facendo un balzo pindarico come piaceva fare a lui, provare a piantarla di insegnare agli altri come devono vivere e con chi possono sposarsi e avere figli e magari, rendendo nostra la pratica della tolleranza, trovare qualcosa di meglio da fare che tormentare chi è diverso da noi? Ne ricaverebbero vantaggio anche l’orto, il taglio e cucito e persino Facebook.
Non si dice di essere troppo tolleranti con tutto, per carità. Ma accidenti il discrimine si può trovare, o almeno si può cercare di trovarlo. Sentite cosa diceva a riguardo un povero paesanotto dismorfico vissuto circa due secoli fa: “Nessuna qualità umana è più intollerabile nella vita ordinaria, né in fatti tollerata meno, che l’intolleranza.” Si chiamava Giacomo Leopardi. Puzzava e aveva la gobba. Ora Umberto è lì con Giacomo che guarda il buio oltre la siepe, che siamo noi qui a scannarci in immensa miseria. Sarebbe un bel gesto da parte nostra accendere un lumino in loro onore, accendendo il cervello.